Il tasso di recidive riguardante la distorsione laterale di caviglia è alta, con la possibilità che distorsioni ripetute portino a instabilità cronica della caviglia (Chronic Ankle Instability - CAI). Dal momento che ancora non esiste una visione comune sui i fattori che contribuiscono al CAI, è indispensabile individuare le cause e prevenire le distorsioni laterali recidive.
Un fattore che è stato recentemente proposto è una differenza di posizione del perone distale in individui con CAI, rispetto al loro lato controlaterale.
Mentre ricerche precedenti hanno trovato coerenza per quanto riguarda il posizionamento antero-posteriore, lo studio ha esaminato disallineamento medio-laterale in individui CAI.
I risultati hanno mostrato che i 17 soggetti con CAI monolaterale possedevano uno spostamento laterale del perone significativamente maggiore rispetto alla caviglia controlaterale. In aggiunta, non hanno evidenziato differenze di posizionamento nel piano sagittale (direzione antero-posteriore).
Anche se questo studio ha evidenziato la presenza di un disallineamento della porzione distale del perone in pazienti con CAI in situazioni di scarico, sono necessari ulteriori studi per rafforzare questi risultati, cercando comparazioni con individui non-CAI.
Concludendo, gli Autori suggeriscono che l'aumento di spostamento laterale del perone può essere un fattore predisponente alle recidive per le distorsioni laterali di caviglia.
da: Kobayashi et al, J Orthop Sport Phys Ther (2014) (Epub ahead of print).
Tutti i diritti riservati a Journal of Orthopaedic Sports & Physical Therapy.
Immagine tratta da justphysio.com.
Questo blog è dedicato a tutti coloro che aspirano a stare meglio e credono che fare movimento alimentandosi in modo consapevole sia la maniera migliore per scaricare lo stress e prevenire futuri acciacchi. Porto la mia esperienza di professionista sul campo ma sarò più obiettivo possibile per darvi informazioni corrette ed aggiornate. “Perchè stare meglio è un bene...ma stare bene è meglio”
Le variabili dell’allenamento: Il carico relativo
ARTICOLO TRATTO DA: BODYBUILDING-NATURAL.COM
AUTORE: Andrea Spadoni
Introduzione
Se i carichi pesanti portino ad una maggiore ipertrofia rispetto a quelli piu leggeri è una materia che ha acceso un feroce dibattito, sia in ambito scientifico sia sui forum di sport di resistenza
in tutto il mondo. Sfortunatamente questi dibattiti spesso degenerano in argomenti improduttivi a causa di una mancanza di conoscenze da uno o da entrambi i lati per quanto riguarda la reale portata delle evidenze attualmente disponibili,quantomeno a lungo termine
Qual è il contesto?
Perché abbiamo bisogno di sapere che cosa dicono gli studi sull’allenamento?
Brad Schoenfeld ha compiuto esaurienti discussioni di questo in almeno due dei suoi articoli di revisione meritatamente lodati (Schoenfeld, 2010 e 2013 ). Tuttavia c’è una mancanza di consapevolezza di dove le evidenze che provengono dagli studi in cronico finiscono e iniziano quelle degli studi a breve termine . Anche se questo potrebbe sembrare una distinzione sterile, in realtà è un punto
piuttosto importante. Gli studi in cronico sull’ipertrofia non ci dicono come una variabile colpisce direttamente la dimensione muscolare. Essi misurano le dimensioni del muscolo prima e dopo e, a meno che non ci sia un grave difetto nello studio, questo fornisce una base per formulare le raccomandazioni. D’altronde, studi acuti misurano le variabili fisiologiche a breve termine le quali possono far pensare ad un corrispettivo guadagno muscolare a lungo termine. Il problema cosi facendo è che la misurazione è indiretta e il sistema fisiologico umano è estremamente complesso cosa che porta ad un rischio di errore elevato.
In precedenza, le prove derivanti da studi acuti suggerivano che dovremmo costruire allenamenti intorno alla loro capacità di causare un aumento significativo degli ormoni anabolici 
post-allenamento . Questo è diventato inutile o almeno molto ridimensionato (Schoenfeld 2013b) . Pertanto, è cosa buona tener di conto in primo luogo dalla letteratura cronica, che può
essere considerato come prova forte, e in secondo luogo dal letteratura acuta, che deve essere considerata debole (ma ancora molto importante come prova) . Questa recensione è destinata a fornire una sintesi della letteratura cronica.
Come fa il carico relativo ad influenzare l’ ipertrofia?
I seguenti studi hanno valutato le diferenze dell’ ipertrofia che derivano dall’utilizzo di carichi pesanti vs. carichi leggeri in soggetti non allenati, nei soggetti allenati non sembra esserci traccia in letteratura
Scheunke ( 2012 ) – I ricercatori hanno reclutato 34 donne inesperte per un programma di 6 settimane e con una suddivisione per gruppi in questo modo
a bassa velocità (6 – 10RM con 10 secondi e concentrica 4 secondi eccentrico, o 40 – 60% di 1RM), A(6 – 10RM con 1-2 secondi concentrica e 1-2-
secondo eccentrica o 80 – 85% di 1RM), B (20 – 30RM con 1-2 secondi concentrica e 1-2- secondo eccentrico o 40 – 60% dell’1RM) C
e il gruppo di controllo. I soggetti si sono allenati due giorni a settimana per la prima e poi 3 giorni a settimana per le restanti in esercizi di leg press, squat e di
estensioni del ginocchio con 2 minuti di riposo tra i set. Prima e dopo il periodo di 6 settimane, i ricercatori hanno condotto le biopsie per valutare la composizione delle fibre muscolari e la sezione trasversale.L’uso A ha aumentato le fibre di tipo I e di tipo IIA rispettivamente del 26,6 ± 22,7% e 32,9 ± 20,4%, i guadagni dei quali erano significativamente maggiori rispetto agli altri gruppi.
Inoltre,il gruppo A ha aumentato la fibra IIX del 41,1 ± 32,7%, che era significativamente superiore al controllo. Questo era l’unica differenza significativa.Cambiamenti nel tipo IIX tipo fibra tra i gruppi.
Campos (2002) – I ricercatori hanno reclutato 32 persone di sesso maschile per un programma di resistenza di 8 settimane e sono stati cosi divis: basse ripetizioni (3 – 5RM per 4 set di
ogni esercizio con 3 minuti di riposo tra le serie e esercizi), un gruppo a ripetizioni medie (9 – 11RM per 3 set con 2 minuti di riposo), un gruppo ad alte ripetizioni (20 – 28RM per 2
imposta di 1 minuti di riposo), e un gruppo di controllo I soggetti hanno eseguito leg press, squat, e estensione del ginocchio 2 giorni a settimana per le prime 4 settimane e 3 giorni
a settimana per le seconde 4 . I ricercatori hanno compiuto le biopsie muscolari prima e dopo per valutare la composizone delle fibre e la sezione trasversale . I ricercatori hanno osservato
aumenti nella sezione trasversale di tutti 3 principali tipi fibra (tipo I, IIA, e IIX) nelle basse rep e nel gurppo a medie, ma non hanno osservato alcun aumenti significativo nel gurppo ad alte ripetizioni e di controllo
Holm ( 2008) – I ricercatori hanno reclutato 11 sedentario maschi per un programma di 12 settimane che prevedeva un allenamento 3 volte alla settimana, con una gamba al 70% di 1RM
(Carico pesante) e l’altra gamba al 15,5% dell’1RM (carico leggero).Prima e dopo i ricercatori hanno misurato la sezione trasversale muscolare tramite risonanza magnetica (MRI) e biopsie. Hanno riferito che la sezione trasversale del quadricipite è aumentata 8 ± 1% e 3 ± 1% sia nell’allenamento pesante siain quello leggero e che le differenze erano irrilevanti.
Popov (2006) – i ricercatori hanno reclutato 18 giovani, maschi fisicamente attivi per un intervento di 8 settimane, in cui hanno allenato i muscoli estensori della gamba 3 volte a settimana. Il gruppo pesante ha lavorato all’ 80% di MVC mentre il gruppo leggero ha lavorato al 50% di MVC. Prima e dopo risonanze e biopsie. I ricercatori hanno scoperto che il gruppo pesante aveva aumentato la sezione trasversale muscolare del 17% e il gruppo leggero del 9%. Tuttavia, questa differenza non era statisticamente di rilievo.
Tanimoto ( 2008) – I ricercatori hanno reclutato 36 soggetti sani di sesso maschile, ma inesperti, che hanno eseguito su tutto il corpo un allenamento con i pesi 2 volte a settimana per 13 settimane con 3 set di squat,bench rpess e lat-pull-down,abdominal bend, e back extencion. I soggetti sono stati divisi in 3 gruppi: carico leggero (55 – 60% di 1RM con 3- secondo eccentrico e le azioni concentriche), pesante (80 – 90% di 1RM con 1 secondo concentrico e le azioni eccentriche e una pausa di 1 secondo) e un controllo. Prima e dopo i ricercatori hanno misurato lo spessore del muscolo
utilizzando gli ultrasuoni. I ricercatori hanno scoperto che l’aumento dello spessore muscolare era simile nel gruppo a carico leggero (6,8 ± 3,4% in somma di sei siti) ed in quello pesante (9,1 ± 4,2%). Tuttavia, il gruppo pesante ha mostrato una tentenza non significante di maggior aumento rispetto al gruppo leggero
Van Roie ( 2013) – i ricercatori hanno confrontato gli effetti di alta e basso carico sul volume muscolare in 56 adulti più anziani che svolgono un programma di 12 settimane di leg press e di leg extencion, alto carico (2 × 10- 15 ripetizioni al 80% del 1RM, basso (1 × 80-100 ripetizioni a 20% di 1RM), o basso + (1 × 60 ripetizioni al 20% dell’1RM, seguito da 1 × 10-20 ripetizioni a 40% di 1RM). Non c’era differenza significante sull’ aumento del volume muscolare tra i gruppi. Il volume muscolare della coscia è aumentato in modo significante nel gruppo con un alto carico (+ 3,2 ± 3,7%), e nei gruppi a basso carico (+2,4 ± 2,7%) e (+ 2,6 ± 3,8%). C’era quindi una tendenza non significante a favore del gruppo con maggior carico
Tanimoto ( 2008 ) – I ricercatori hanno reclutato 24 soggetti sani, ma inesperti giovani maschi che hanno eseguito su tutto il corpo un allenamento 3 volte alla settimana per 12 settimane con 3 set di esercizio di estensione del ginocchio. I soggetti sono stati assegnati in 3 gruppi: carico leggero-velocita lenta (50% dell’1RM con 3 secondi azioni eccentriche e concentriche), carico leggero-velocità normale (50% di 1RM con 1 secondo eccentrico e le azioni concentriche e 1- secondi di pausa), e pesante (80% di 1RM con 1 secondo azioni concentriche ed eccentriche e una pausa di 1 secondo).
Prima e dopo i ricercatori hanno misurato la sezione trasversale con la risonanza magnetica. Il ricercatori hanno scoperto che l’area della sezione trasversale del quadricipite è aumentata di 5,4 ± 3,7% nel gruppo carico leggero-velocita lenta e di 4,3 ± 2,1% nel gruppo pesante ma non c’era alcun aumento nel gruppo carico leggero-velocità normale . Non c’era differenze significative
tra l’aumento quadricipite sezione trasversale tra i il gruppo leggero e pesante
Leger ( 2006) – I ricercatori hanno reclutato 25 maschi sani,allenati, per un allenamento di 8 settimane da de-allenamento.I soggetti sono stati
inseriti in due gruppi (basso numero di ripetizioni o alte ripetizioni) e sono stati abbinati per età, altezza, peso, VO2-max e forza e resistenza muscolare. I soggetti hanno eseguito lo stesso protocollo di allenamento come descritto in Campos (2002) di cui sopra e i ricercatori hanno misurato la sezione trasversale prima e dopo l’intervento. I ricercatori hanno osservato un aumento
della sezione trasversale del quadricipite di circa il 10% in entrambi i gruppi senza differenze significanti tra i gruppi.
Mitchell (2012) – I ricercatori hanno reclutato 18 uomini sani e allenati per uno studio di 10 settimane in cui si è eseguito per una sola gamba un allenamento con i pesi 3 volte alla settimana.
I ricercatori hanno casualmente assegnato ciascuno dei soggetti ‘ad un protocollo di allenamento, come segue: 30% dell’1RM x 3 set, 80% di 1RM x 1 set, e l’80% di 1RM x 3 set. Prima
e dopo l’intervento, i ricercatori hanno misurato il volume muscolare tramite MRI. I ricercatori hanno riferito che tutti e 3 i gruppi hanno avuto un aumento del volume muscolare significativamente
simile (30% -3 = 6,8 ± 1,8%, 80% -1 = 3,2 ± 0,8%, e 80% – 3 = 7,2 ± 1,9%), anche se c’era una tendenza ad un maggior volume per i gruppi con piu set sebbene non significativa
Ogasawara ( 2013) – i ricercatori hanno reclutato 9 giovani, maschi addestrati per 6 settimane, hanno compiuto un programma usando un alto carico nella distensione su panca con 75% di 1RM per 3 set, 3 volte a settimana, seguito da un periodo di non allenamento di 12 mesi, seguito da 6 settimane con un programma a basso carico con il 30% di 1RM per 4 set, 3 volte a settimana.
Prima e dopo allenamento di 6 settimane, i ricercatori hanno misurato l’area della sezione trasversale muscolare del tricipite brachiale e dei pettorali utilizzando la risonanza magnetica. Hanno riferito
che la sezione trasversale muscolare per entrambi i muscoli, con il grande carico è aumentata dell’ 11,9% e del 17,6%,mentre con il basso carico del 9,8% e del 21,1% . Tuttavia,
non c’erano differenze significative tra i gruppi.
Qual è il riassunto dei risultati?
In sintesi, questo non è un semplice insieme di studi che forniscono conclusioni nette. Inoltre, abbiamo sempre bisogno di ricordare che tutti gli studidi sopra sono stati eseguiti quasi tutti da soggetti
non addestrati. Tuttavia, la la letteratura può essere analizzata come segue:
Differenze significative – i primi 3 studi (es Scheunke,2012 , Campos, 2002 e Holm, 2008) hanno trovato significative differenze tra gruppi con alto e basso carico,con vantaggi per l’alto carico
Differenze non significative – I prossimi 3 studi (es Popov,2006 , Tanimoto, 2008, E Van Roie, 2013 ) hanno riportato differenze non significative fra alto e basso carico, con tentenze a favore dell’alto carico
Nessuna differenza – I 4 studi finali i (Tanimoto,2006 , Leger,2006b, Mitchell, 2012 , E Ogasawara, 2013 ) Non hanno trovato differenze. Questo completa mancanza di accordo indica che è molto
difficile al momento dare una risposta definitiva sulla superiorità dei carichi pesanti (ovvero> 65% di 1RM) rispetto ai carichi leggeri (<65% di 1RM) per l’ipertrofia muscolare negli individui allenati
Qual è la linea di fondo?
C’è qualche evidenza che i carichi leggeri sono in grado di produrre ipertrofia, è possibile che questo grado di ipertrofia possa essere leggermente inferiore a quella ottenibile con carichi più pesanti.
Quali sono le implicazioni pratiche?
Quando si lavora con i principianti non allenati, carichi piu leggeri (+ 15RM o <65% di 1RM) sono in grado di produrre ipertrofia.Tale ipertrofia può essere simile o solo leggermente inferiore a quella ottenibile con carichi più pesanti e ciò può consentire una maggiore varietà e almeno all’inizio un impegno inferiore per il principiante.
Altre considerazioniMi sembra che sia che sia chiaro che almeno per il carico sia chiaro al momento considerare la periodizzazione come una priorità senza escludere carichi piu leggeri,carichi piu pesanti.
Articolo tratto dal libro “TRAINING FOR HYPERTROPHY” di Chris Beardsley
Le variabili dell’allenamento: Il volume
ARTICOLO TRATTO DA: BODYBUILDING-NATURAL.COM
AUTORE: Andrea Spadoni
Insieme con il cedimento e l’importanza dei carichi pesanti , gli effetti del volume di allenamento sull’ ipertrofia è un argomento altamente controverso per i professionisti della forza, allenatori di bodybuilding e personal trainer.
Ecco un riassunto di quello che sappiamo …
Studi in cronico che misurano gli effetti delle variabili sulla ipertrofia, tra cui il volume, sono pochi e rari. Inoltre, ci sono vari problemi associati a questa area della letteratura, in particolare quelli per cui i guadagni in ipertrofia sono molto più piccoli dei guadagni di forza e che tali guadagni tendono a mostrare un grande quantità di variabilità tra i soggetti (ad esempio Hubal 2005).
Inoltre, gli studi tendono a coinvolgere relativamente pochi soggetti e per breve durata. Questi fattori indicano che il rischio di errore di tipo e II (mancata identificazione di significative differenze ) è elevato negli studi cronici, come Krieger 2010, ha rilevato in una recente meta-analisi.
Krieger ha osservato che esiste il rischio che, se gli studi sono costantemente eseguiti riportando effetti non significanti su una variabile, questo potrebbe portare a una falsa impressione dei veri effetti di questa variabile.Questo è all’origine della meta-analisi, al termine della quale si è concluso che più set sono associati con il 40% di maggiori dimensioni dell’ipertrofia rispetto ai singoli gruppi, sia in persone non allenati che in quelle allenate. Tuttavia, Fisher 2012 ha fatto una critica dettagliata della meta-analisi di Krieger.
Fisher ha suggerito che la meta-analisi non ha il controllo e non analizza lo stato di allenamento dei soggetti interessati,che, come osservato in precedenza potrebbe fare un differenza marcata
per la capacità di aumentare la massa muscolare nel breve termine. Fischer inoltre ha proposto che i differenti carichi relativi sono stati utilizzati negli studi , in un range fra 6 – 8RM fino a 15 ripetizioni.
Fisher esorta i ricercatori anche a prestare ulteriori attenzioni quando compiono meta-analisi.
per la capacità di aumentare la massa muscolare nel breve termine. Fischer inoltre ha proposto che i differenti carichi relativi sono stati utilizzati negli studi , in un range fra 6 – 8RM fino a 15 ripetizioni.
Fisher esorta i ricercatori anche a prestare ulteriori attenzioni quando compiono meta-analisi.
Qual è l’effetto del volume sull’ipertrofia?
I seguenti studi in cronico hanno esplorato gli effetti di volumi differenti sia su esperti che su atleti inesperti . Questa analisi è divisa in due sezioni. La prima sezione è fatta di otto studi inclusi nella meta-analisi di Krieger .
La seconda sezione riguarda quelle prove che sono state pubblicate in seguito a quella meta-analisi.
La seconda sezione riguarda quelle prove che sono state pubblicate in seguito a quella meta-analisi.
Galvao 2005 ha eseguito uno studio randomizzato in 28 uomini e donne di età compresa tra 65-78 anni.I soggetti sono stati assegnati ad un gruppo di 1 set o ad un altro per 3 set e entrambi i gruppi hanno eseguito un allenamento con una resistenza progressiva composta da sette esercizi per i gruppi muscolari principali sia della parte superiore del corpo che inferiore due volte alla settimana per 20 settimane con un carico da 8RM. I ricercatori hanno riferito che non vi era alcuna differenza tra i gruppi per quanto riguarda le variazione nella composizione corporea
Marzolini 2008 ha valutato l’allenamento con i pesi,in gruppi ad 1 set o a 3 , se combinato con l’allenamento aerobico in 72 soggetti con malattia coronarica, anche se solo 53
soggetti con un’età media di 61 ± 2 anni hanno completato il protocollo. Il gruppo a 3-set ha aumentato la massa magra non significativamente maggiore rispetto al gruppo ad 1 set
soggetti con un’età media di 61 ± 2 anni hanno completato il protocollo. Il gruppo a 3-set ha aumentato la massa magra non significativamente maggiore rispetto al gruppo ad 1 set
McBride (2003) ha confrontato gli effetti di un programma di 12 settimane in due gruppi divisi a 1 set o 6-set di 28 maschi e femmine non allenati,per due volte a settimana, la
massa corporea delle gambe e delle braccia è stata misurata. I ricercatori non hanno trovato significative differenze nei guadagni di massa magra per le gambe o le braccia.
massa corporea delle gambe e delle braccia è stata misurata. I ricercatori non hanno trovato significative differenze nei guadagni di massa magra per le gambe o le braccia.
Munn (2005) ha confrontato gli effetti sulla circonferenza del braccio nella prima fase di allenamento con i pesi, con 1 o 3 set e con velocità sia veloce che lenta. Essi hanno scoperto che 3 serie hanno prodotto miglioramenti nella forza rispetto ad 1 set ma non è stata trovata alcuna significativa differenza tra i gruppi per la circonferenza del braccio
Ostrowski (1997) ha studiato gli effetti di differenti volumi (1 set contro 3 set) di allenamento con i pesi sulle dimensioni del muscolo nel corso di un periodo di 10 settimane in 27 maschi con 1 – 4
anni di esperienza con i pesi, allenamento 4 volte a settimana.
Gli ultrasuoni sono stati utilizzati per misurare i distretti muscolari. I ricercatori hanno segnalato che non vi erano significative differenze tra i gruppi,anche se si sono registrati aumenti significativi nella sezione trasversale dei vari distretti in ciascuno dei gruppi.
anni di esperienza con i pesi, allenamento 4 volte a settimana.
Gli ultrasuoni sono stati utilizzati per misurare i distretti muscolari. I ricercatori hanno segnalato che non vi erano significative differenze tra i gruppi,anche se si sono registrati aumenti significativi nella sezione trasversale dei vari distretti in ciascuno dei gruppi.
Rønnestad (2007) ha confrontato gli effetti di un singolo set o 3 set di allenamento con i pesi per l’ipertrofia in 21 maschi non allenati, allenamento di 3 giorni alla settimana per 11 settimane
con carichi di 7 – 10RM. Si è constatato che la sezione trasversale della coscia è aumentata di più nel gruppo a 3 set rispetto al gruppo ad 1 set (16 vs 8%), ma non c’erano signiificative differenze
tra i gruppi per quanto riguarda la sezione trasversale del trapezio superiore.
con carichi di 7 – 10RM. Si è constatato che la sezione trasversale della coscia è aumentata di più nel gruppo a 3 set rispetto al gruppo ad 1 set (16 vs 8%), ma non c’erano signiificative differenze
tra i gruppi per quanto riguarda la sezione trasversale del trapezio superiore.
Rhea (2002) ha osservato i gruppi con 1-set e 3 set di allenamento con i pesi in 16 giovani maschi allenati,allenamento 3 giorni a settimana per 12 settimane sulla panca e leg press con carichi da 4 – 8RM . Tuttavia, nessuno dei due gruppi ha avuto cambiamenti significativi
Starkey (1996) ha valutato gli effetti di volumi differenti di allenamento sullo spessore del muscolo in 10 soggetti sani non allenati con un allenamento 3 volte alla settimana utilizzando
un set o tre set che sono stati eseguiti a fatica con 8 -12 ripetizioni per un periodo di 14 settimane. Prima e dopo l’allenamento, i ricercatori hanno valutato lo spessore muscolare in vari punti lungo la gamba usando gli ultrasuoni.
I ricercatori hanno scoperto un aumento dello spessore del muscolo per entrambi i gruppi nei muscoli quadricipiti sia per il gruppo ad 1-set che a 3 set.
un set o tre set che sono stati eseguiti a fatica con 8 -12 ripetizioni per un periodo di 14 settimane. Prima e dopo l’allenamento, i ricercatori hanno valutato lo spessore muscolare in vari punti lungo la gamba usando gli ultrasuoni.
I ricercatori hanno scoperto un aumento dello spessore del muscolo per entrambi i gruppi nei muscoli quadricipiti sia per il gruppo ad 1-set che a 3 set.
Dalla recente meta-analisi eseguita da Krieger, ci sono stati almeno tre ulteriori studi sugli effetti del volume sullipertrofia,in varie popolazioni, come segue:
Bottaro (2011) ha confrontato gli effetti dell’allenamento con i pesi e il volume sugli adattamenti dei gruppi muscolari nei giovani maschi, assegnati in modo casuale in due gruppi,
uno che ha eseguito 3 set di estensione del ginocchio e 1 set di flessione del gomito o 1 set di estensioni del ginocchio e 3 set di flessione del gomito, con un allenamento 2 giorni a settimana per 12 settimane. l ricercatori hanno scoperto che lo spessore del muscolo del flessore del gomito è aumentato significativamente per entrambi i gruppi, mentre le modifiche nello spessore del muscolo quadricipite non erano significativamente differenti per entrambi i gruppi. Essi hanno scoperto che, anche se non ci fossero differenze significative tra i gruppi, c’è stato un tendenza non significativa per il gruppo con un volume superiore.
uno che ha eseguito 3 set di estensione del ginocchio e 1 set di flessione del gomito o 1 set di estensioni del ginocchio e 3 set di flessione del gomito, con un allenamento 2 giorni a settimana per 12 settimane. l ricercatori hanno scoperto che lo spessore del muscolo del flessore del gomito è aumentato significativamente per entrambi i gruppi, mentre le modifiche nello spessore del muscolo quadricipite non erano significativamente differenti per entrambi i gruppi. Essi hanno scoperto che, anche se non ci fossero differenze significative tra i gruppi, c’è stato un tendenza non significativa per il gruppo con un volume superiore.
Sooneste (2013) ha studiato i vari effetti sull’ipertrofia nelle braccia dello stesso soggetto con volumi di allenamento differenti (1 o 3
set) in 8 sedentari, non allenati giapponesi . l soggetti sono stati allenati 2 volte a settimana per 12 settimane con curl seduti con il 80% di 1RM. I ricercatori hanno riferito che il gruppo che eseguiva il protocollo con 3-set ha aumentato la sezione trasversale significativamente di più rispetto al protocollo ad 1 set.
set) in 8 sedentari, non allenati giapponesi . l soggetti sono stati allenati 2 volte a settimana per 12 settimane con curl seduti con il 80% di 1RM. I ricercatori hanno riferito che il gruppo che eseguiva il protocollo con 3-set ha aumentato la sezione trasversale significativamente di più rispetto al protocollo ad 1 set.
Radaelli (2013) ha confrontato gli effetti di basso e alto volume di allenamento per la forza dello spessore muscolare della parte superiore e inferiore del corpo in 20 donne sane, più anziane. I soggetti
sono stati randomizzati in due gruppi: a basso volume e ad alto volume, dove il gruppo a basso volume ha eseguito 1-set di ogni esercizio, mentre il gruppo ad alto volume eseguita 3- serie di ogni esercizio, 2 volte a settimana per 13 settimane. I ricercatori hanno scoperto che tutte le misurazioni dello spessore del muscolo della parte superiore e inferiore del corpo era aumentata in modo simile in entrambi gruppi. Tuttavia, c’è stata una tendenza non significativa per il gruppo ad alto volume rispetto al gruppo a basso volume
sono stati randomizzati in due gruppi: a basso volume e ad alto volume, dove il gruppo a basso volume ha eseguito 1-set di ogni esercizio, mentre il gruppo ad alto volume eseguita 3- serie di ogni esercizio, 2 volte a settimana per 13 settimane. I ricercatori hanno scoperto che tutte le misurazioni dello spessore del muscolo della parte superiore e inferiore del corpo era aumentata in modo simile in entrambi gruppi. Tuttavia, c’è stata una tendenza non significativa per il gruppo ad alto volume rispetto al gruppo a basso volume
Qual è il riassunto dei risultati?
In sintesi, da tutti gli 11 studi per valutare la differenze tra basso e alto volume di allenamento per l’ipertrofia,3 hanno trovato benefici statisticamente significanti a favore del maggior volume, 7 hanno trovato differenze non significative nell’utilizzo di maggior volume (che possono o non possono essere causa di un errore di tipo II), e 1 studio non ha trovato alcun beneficio utilizzando un volume piu alto, anche se questo studio ha utilizzato forse il metodo di misurazione più inaffidabile per l’ipertrofia (circonferenza del braccio). Nei soggetti gia allenati, gli unici 2 studi che sono stati effettuati finora non hanno trovato significativi benefici nell’utilizzo di un volume maggiore (che di nuovo può onon essere a causa di un errore di tipo II).
In sintesi, da tutti gli 11 studi per valutare la differenze tra basso e alto volume di allenamento per l’ipertrofia,3 hanno trovato benefici statisticamente significanti a favore del maggior volume, 7 hanno trovato differenze non significative nell’utilizzo di maggior volume (che possono o non possono essere causa di un errore di tipo II), e 1 studio non ha trovato alcun beneficio utilizzando un volume piu alto, anche se questo studio ha utilizzato forse il metodo di misurazione più inaffidabile per l’ipertrofia (circonferenza del braccio). Nei soggetti gia allenati, gli unici 2 studi che sono stati effettuati finora non hanno trovato significativi benefici nell’utilizzo di un volume maggiore (che di nuovo può onon essere a causa di un errore di tipo II).
Qual è la linea di fondo?
In conclusione, l’utilizzo di più set x raggiungere un maggior volume di allenamento sembra portare ad una maggiore ipertrofia rispetto all’uso di singole serie o un volume inferiore di allenamento.
Tuttavia, la letteratura è afflitto da una mancanza di studi di qualità con potenza statistica sufficiente e questa conclusione si base solo su prove pressoche indiziarie
In conclusione, l’utilizzo di più set x raggiungere un maggior volume di allenamento sembra portare ad una maggiore ipertrofia rispetto all’uso di singole serie o un volume inferiore di allenamento.
Tuttavia, la letteratura è afflitto da una mancanza di studi di qualità con potenza statistica sufficiente e questa conclusione si base solo su prove pressoche indiziarie
Quali sono le implicazioni pratiche?
L’allenamento con più set sembra dare una maggiore ipertrofia,indipendentemente dallo stato di allenamento ed età. Inoltre, sembra esserci una risposta tanto maggiore tanto è l’aumento di volume anche se non è chiaro fino a che punto questo possa aumentare. Infine, la legge dei rendimenti decrescenti sembra applicarsi all’alleamento per l’ ipertrofia:
il primo set può essere il più importante e ogni set successivo dare uno stimolo minore .
Pertanto, per coloro che sono a corto di tempo,fare un minor numero di set può essere comunque una scelta appropriata.
L’allenamento con più set sembra dare una maggiore ipertrofia,indipendentemente dallo stato di allenamento ed età. Inoltre, sembra esserci una risposta tanto maggiore tanto è l’aumento di volume anche se non è chiaro fino a che punto questo possa aumentare. Infine, la legge dei rendimenti decrescenti sembra applicarsi all’alleamento per l’ ipertrofia:
il primo set può essere il più importante e ogni set successivo dare uno stimolo minore .
Pertanto, per coloro che sono a corto di tempo,fare un minor numero di set può essere comunque una scelta appropriata.
Articolo tratto dal libro “TRAINING FOR HYPERTROPHY” di Chris Beardsley
Le 11 bugie più grosse (e pericolose) che si sentono ripetere quando si parla di Nutrizione
L'articolo contiene anche i vari riferimenti scientifici alle affermazioni fatte.
1. Eggs Are Unhealthy - Le uova fanno male.
Le uova non causano malattie cardiache e sono tra i cibi più nutrienti del pianeta. Mangiare uova per la prima colazione può aiutare a perdere peso.
2. Saturated Fat is Bad For You - I grassi animali fanno male.
Recenti studi hanno dimostrato che i grassi saturi non causa malattie cardiache.
3. Everybody Should be Eating Grains - Tutti dovrebbero mangiare cereali.
I cereali sono alimenti relativamente poveri di sostanze nutrienti rispetto ad altri alimenti come le verdure. Il glutine contenuto, poi, può essere causa di vari problemi di salute.
4. Eating a Lot of Protein is Bad For Your Bones and Kidneys - Mangiare molte proteine fa male ai reni e alle ossa.
Mangiare una dieta ricca di proteine è porta ad una migliore salute delle ossa e ad un minor rischio di frattura; abbassa anche la pressione sanguigna e migliora i sintomi del diabete (che dovrebbe ridurre il rischio di insufficienza renale).
5. Low-Fat Foods Are Good For You - I cibi con pochi grassi fanno bene.
I cibi a basso contenuto di grassi sono solitamente prodotti altamente "trasformati" a livello industriale, sono carichi di zucchero, sciroppo di mais o dolcificanti artificiali...
6. You Should Eat Many Small Meals Throughout The Day - Bisogna mangiare poco e spesso.
Non ci sono prove che mangiare molti piccoli pasti durante la giornata sia meglio di un minor numero di pasti ma più grandi. E non fa nemmeno così male digiunare ogni tanto.
Piuttosto, si è visto come aumentare la frequenza dei pasti è correlato all'insorgenza del cancro al colon.
7. Carbs Should Be Your Biggest Source of Calories - I carboidrati dovrebbero fornire il grosso delle calorie che mangiamo.
La dieta a basso contenuto di grassi e a (inevitabile) più alto contenuto di carboidrati è fallimentare (ed è stato dimostrato più volte) rispetto a quelle, a contrario, a basso contenuto di carboidrati ed alto contenuto di grassi.
8. High Omega-6 Seed and Vegetable Oils Are Good For You - Gli oli di semi fanno bene.
Gli esseri umani hanno bisogno di ottenere grassi Omega-6 e Omega-3 in un determinato rapporto. Mangiare in eccesso Omega-6, ottenuti per esempio dagli oli di semi, aumenta il rischio di malattie.
9. Low Carb Diets Are Dangerous - Le diete con pochi carboidrati fanno male.
Le diete a basso contenuto di carboidrati sono la più sana, semplice ed efficace scelta per perdere peso e invertire la malattia metabolica. È un fatto scientifico.
10. Sugar is Unhealthy Because it Contains “Empty” Calories - Lo zucchero fa male perché contiene calorie "vuote" (i motivi per cui fa male sono altri).
Gli effetti nocivi di zucchero vanno ben al di là della questione calorica.
11. High Fat Foods Will Make You Fat - Mangiare grasso fa ingrassare.
Una dieta ad alto contenuto di grassi e di carboidrati ASSIEME fa ingrassare.
Dove va il grasso quando si dimagrisce...?
La maggior parte delle persone ritiene che il grasso venga convertito in energia o calore, il che viola la legge della conservazione della massa.
Abbiamo il sospetto che questo equivoco è causato dalla "energia in entrata\energia in uscita " [...] Altre idee sono sbagliate come che il grasso venga eliminato con le feci o si trasformi in muscolo...
La risposta in questo studio:
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257
Questi risultati mostrano che i polmoni sono l'organo di escrezione principale per la perdita di peso. L'acqua che si forma può essere espulsa con le urine, le feci, il sudore, il respiro, le lacrime, o altri fluidi corporei.
I calcoli che vedete mostrano che i polmoni sono l'organo escretore principale per il grasso.
Perdere peso richiede sbloccare il carbonio immagazzinato nelle cellule adipose, rafforzando quello che spesso si è sentito "mangiare meno, muoversi di più".
Abbiamo il sospetto che questo equivoco è causato dalla "energia in entrata\energia in uscita " [...] Altre idee sono sbagliate come che il grasso venga eliminato con le feci o si trasformi in muscolo...
La risposta in questo studio:
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257
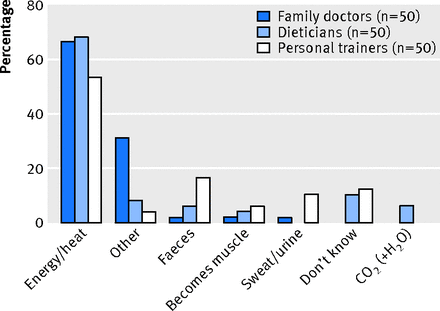 |
| Responses of a sample of doctors, dieticians, and personal trainers to the question “When somebody loses weight, where does it go?” (Correct answer CO2) |
Questi risultati mostrano che i polmoni sono l'organo di escrezione principale per la perdita di peso. L'acqua che si forma può essere espulsa con le urine, le feci, il sudore, il respiro, le lacrime, o altri fluidi corporei.
I calcoli che vedete mostrano che i polmoni sono l'organo escretore principale per il grasso.
Perdere peso richiede sbloccare il carbonio immagazzinato nelle cellule adipose, rafforzando quello che spesso si è sentito "mangiare meno, muoversi di più".
Dieta iperproteica e senso di fame: dipende dal DNA
 Tralasciamo, per il momento, le considerazioni sull'efficacia e soprattutto sulla sicurezza di utilizzare una dieta iperproteica - specie di quelle offerte da personale non qualificato - ed addentriamoci subito nel cuore di questo articolo.
Tralasciamo, per il momento, le considerazioni sull'efficacia e soprattutto sulla sicurezza di utilizzare una dieta iperproteica - specie di quelle offerte da personale non qualificato - ed addentriamoci subito nel cuore di questo articolo.Il gene incriminato è il gene FTO, più volte preso in causa in questo blog, in quanto presenta una variante comune nel rischio di obesità ed è stato recentemente dimostrato influenzare l'appetito ed essere sensibile alla regolazione degli aminoacidi.
FTO: Gene la cui variante comune rs9939609 identificato come fattore di rischio per l’obesità in uno studio del 2007 di Fraylin et al. La presenza o meno della variante A porta, nel contesto di compresenza di altri polimorfismi e fattori, a una differente risposta al tipo di dieta, all’attività fisica ed al rischio di sviluppare diabete di tipo II in caso di BMI alta. Questo gene è localizzato sil cromosoma 16 e codifica per un enzima noto anche come diossigenasi alfa-chetoglutarato-dipendente.
Il riscontro è stato che gli individui con l’allele FTO rs9939609 hanno ottenuto benefici importanti in termini di diminuzione nel desiderio di cibo e appetito e molto maggiori rispetto agli individui senza questo allele (che avrebbero potuto quindi risparmiarsi gli eventuali effetti collaterali di una dieta simile).
Tra i “pro” dello studio c’è il fatto che i dati sulle variazioni del desiderio di cibo sono stati aggiustati per età, sesso, etnia, indice di massa corporea basale e variazioni di peso; tra i limiti vi è i il fatto che la maggior parte dei partecipanti (80%) fossero bianchi e quindi i risultati sono poco generalizzabili ad altri gruppi etnici e inoltre non è stata fatta alcuna misura della grelina, e dunque l'interazione con questo ormone non ha potuto essere verificata.
Questi nuovi risultati sembrano comunque fornire una piccola prova a sostegno del concetto secondo cui un intervento nutrizionale personalizzato può aiutare nella prevenzione dell’obesità e una possibile risposta alla domanda “con questa dieta avrò meno fame?” sarà: “dipende dal suo DNA, signora”.
Indice e carico glicemico: un pò di chiarezza a tavola
Indice glicemico, se ne parla sempre di più.
Molto spesso però si tende a far confusione.
In generale, ad un indice glicemico più basso è connessa una minore quantità di insulina in circolo nell'organismo e di conseguenza un alleggerimento del lavoro del pancreas. A fare chiarezza ci ha pensato il team di nutrizionisti che di recente ha partecipato al summit mondiale organizzato a Stresa da NFI (Nutrition Foundation of Italy) e Oldways USA. Qui è emersa la necessità di classificare i carboidrati non più in semplici e complessi, o se vogliamo, zuccheri e amidi.
Questo perché non tutti i cibi che contengono zuccheri provocano un rapido aumento della glicemia, e allo stesso modo non tutti gli alimenti che contenengono amidi non sono connessi ai picchi glicemici.
Per prima cosa gli esperti, riuniti a Stresa, hanno ribadito la necessità di una nuova classificazione dei carboidrati, basata su: indice glicemico, carico glicemico e risposta glicemica.
Come fare a sapere quali sono i cibi a bass IG? Spiegano gli esperti che "non esiste un metodo semplice per predire l’IG di un alimento. È necessario ricercare il valore dell’IG in siti web affidabili (quale, ad esempio, www.glycemicindex.com) e in manuali per lo shopping a basso IG. Ma noi italiani siamo già abbastanza avvantaggiati visto che molti degli alimenti a basso IG sono inclusi nella dieta mediterranea tradizionale". Tra essi lenticchie, fagioli, ceci, pasta e orzo. Ecco a titolo di esempio alcuni alimenti ad alto (≥70), medio (56-69) o basso (≤55) Indice Glicemico (IG):
Patate (quasi tutte) 77, pane bianco 70, saccarosio 65, pizza 57, pastasciutta al dente 45, mela 40, legumi 35, pomodori 9. In generale, i carboidrati meno lavorati, meno cotti e più grezzi hanno l’IG e il CG più favorevole. In alcuni paesi (Australia e Nuova Zelanda, come è stato detto) è già applicato un logo agli alimenti, che permette di identificare quelli a basso IG.
Va da sè che i metodi di cottura influenzano l'IG. Infatti, secondo i ricercatori della NFI, più si prolunga la cottura di un alimento ricco di amidi in acqua, più rapida è la digestione enzimatica dei carboidrati, e quindi più alto è il picco glicemico. Al tempo stesso, "la cottura al dente della pasta e del riso, tipica della cultura nazionale italiana, ha quindi anche favorevoli implicazioni di salute".
Perchè è preferibile secondo gli esperti del “Carbohydrate Quality Consortium” consumare i alimenti non solo a basso IG ma anche a bass CG? I vantaggi sono soprattutto quattro: il miglioramento del controllo della glicemia nei pazienti diabetici, la riduzione del rischio di sviluppare il diabete Tipo 2 e malattie cardiovascolari, soprattutto negli individui in sovrappeso e con stili di vita sedentari, il miglioramento dei livelli di colesterolo nel sangue di altri fattori di rischio cardiovascolare e il miglioramento il controllo del peso corporeo.
Fonte:
Molto spesso però si tende a far confusione.
In generale, ad un indice glicemico più basso è connessa una minore quantità di insulina in circolo nell'organismo e di conseguenza un alleggerimento del lavoro del pancreas. A fare chiarezza ci ha pensato il team di nutrizionisti che di recente ha partecipato al summit mondiale organizzato a Stresa da NFI (Nutrition Foundation of Italy) e Oldways USA. Qui è emersa la necessità di classificare i carboidrati non più in semplici e complessi, o se vogliamo, zuccheri e amidi.
Questo perché non tutti i cibi che contengono zuccheri provocano un rapido aumento della glicemia, e allo stesso modo non tutti gli alimenti che contenengono amidi non sono connessi ai picchi glicemici.
Per prima cosa gli esperti, riuniti a Stresa, hanno ribadito la necessità di una nuova classificazione dei carboidrati, basata su: indice glicemico, carico glicemico e risposta glicemica.
L'indice glicemico è un sistema di valutazione della qualità dei carboidrati, basato su un punteggio da 0 a 100, in grado di differenziare quelli che vengono digeriti, assorbiti o metabolizzati velocemente, ossia ad alto indice glicemico (IG o GI), da quelli che lo sono lentamente, ossia a vasso IG. Esso viene calcolato testando, su volontari sani, quanto aumenta la glicemia in risposta al consumo di un alimento contenente una quantità standard di carboidrati (50 grammi), rispetto alla stessa quantità di glucosio (assunto sotto forma di acqua zuccherata). Ad esempio, e esso è pari a 50, significa che l'alimento in questione aumenta la glicemia della metà (50%) rispetto al glucosio.
Il carico glicemico (CG), invece, tiene conto sia della qualità del carboidrato quindi dell'IG, che della quantità presente nella porzione media di un determinato alimento o di una ricetta. Come si ottiene? Basta moltiplicare i grammi di carboidrati presenti in una porzione media per l'IG.
Dal canto suo, la risposta glicemica (RG o GR) è il valore complessivo che indica l'andamento dei livelli di glucosio rilevabili nel sangue dopo aver assunto qualunque alimento contenente carboidrati. Essa varia da persona a persona ed è influenzata dall'alimentazione e dallo stile di vita.
 |
| Fonte foto: http://www.dietapuerari.it |
Va da sè che i metodi di cottura influenzano l'IG. Infatti, secondo i ricercatori della NFI, più si prolunga la cottura di un alimento ricco di amidi in acqua, più rapida è la digestione enzimatica dei carboidrati, e quindi più alto è il picco glicemico. Al tempo stesso, "la cottura al dente della pasta e del riso, tipica della cultura nazionale italiana, ha quindi anche favorevoli implicazioni di salute".
Perchè è preferibile secondo gli esperti del “Carbohydrate Quality Consortium” consumare i alimenti non solo a basso IG ma anche a bass CG? I vantaggi sono soprattutto quattro: il miglioramento del controllo della glicemia nei pazienti diabetici, la riduzione del rischio di sviluppare il diabete Tipo 2 e malattie cardiovascolari, soprattutto negli individui in sovrappeso e con stili di vita sedentari, il miglioramento dei livelli di colesterolo nel sangue di altri fattori di rischio cardiovascolare e il miglioramento il controllo del peso corporeo.
Fonte:
Iscriviti a:
Post (Atom)
"Un viaggio di mille miglia comincia sempre con un primo passo" - Lao Tzu -

















